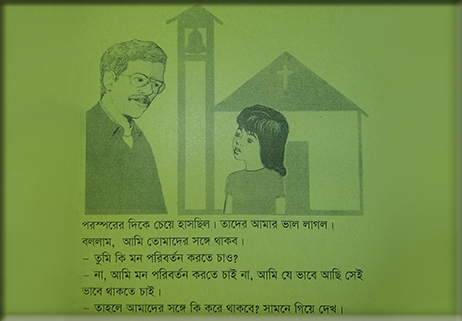LA PARABOLA DI UNA BAMBINA NAUFRAGA
Favole bengalesi che vogliono far riflettere
di p. Antonio Germano Das, sx.
11 gennaio 2018
Back
BREVE PREMESSA. Il racconto, in lingua bengalese, ha un titolo diverso: “La razza umana”. Traducendolo in italiano, ho preferito un titolo diverso, perché non si tratta di un racconto, ma di una parabola con contenuto di alto valore morale e sembra scritta proprio per i tempi che viviamo. Protagonista della parabola è Moni, una bambina naufraga di uno di quei violenti cicloni, che periodicamente si abbattono sulla baia del Bengala. Moni in lingua bengalese significa gioiello, perla, tesoro ed è un nome proprio assai diffuso fra le ragazze. Il contenuto di cui parlavo è che una religione che non va incontro all’uomo, che si trova in una situaione disperata, non è vera religione. In Bangladesh c’è la presenza di 4 grandi religioni: musulmana, induista, cristiana e buddhista. Nessuna di esse ha accolto e si è preso cura della piccola naufraga Moni.La prima domanda che le rivolgono è: “A quale jati appartieni?” Jati (la “J” con pronuncia inglese), parola chiave della parabola, nella cultura bengalese e del sub continente indiano assume una vasta gamma di significati. Etimologicamente è vicino alla parola latina Gens e quasi sempre assume un significato discriminante, può indicare la religione, a cui uno appartiene, come nel caso della parabola, ma normalmente, nell’ampio contesto indiano, che ha ereditato la Dharma Protha dall’induismo, indica la casta o la sotto casta a cui uno appartiene. Alla fine Moni viene accolta con gioia da ragazzi e raggazze come lei, in mezzo ai quali non ci sono barriere di casta o di religione.
Sulla riva del mare a Moheshkhali una bambina di tre anni piange. Mentre si recava a casa del mama (zio materno), nella furia del ciclone aveva perso tutto: la sua bambola, il suo bauletto, le sue scarpette nuove, la sua sciarpetta rossa, ma soprattutto aveva perso il papà e la mamma. Soltanto la palla non l’aveva persa. Aveva legato la palla al petto con la gamcha (un tessuto di cotone che i bengalesi adoperano come asciugamano) in maniera così stretta che neppure il vento impetuoso del ciclone potè strappargliela.
Io conosco il volto di quella ragazza. Quella ragazza sono io. Non so niente di mio padre né di mia madre, non ricordo proprio nulla. So soltanto che, quando si scatenò il ciclone, essi non pensarono a salvare la propria vita, ma misero prima in salvo la mia vita. Essi appartenevano al jati umano.
Io ero lì che dormivo sulla spiaggia del mare. I pescatori mi raccolsero e, affidandomi ad una vecchietta, mi dissero: “La nonna è molto buona, ella si prenderà cura di te”. Io la chiamavo nonna e lei mi voleva bene. In questo modo trascorsi gioiosamente e in piena serenità cinque anni a casa sua. Ma un giorno la nonna si ammalò. Allora ella fece chiamare i capi del villaggio e disse loro: “Prendetevi cura della mia Moni; quando sarà grande, provvedete a darle un buon marito. Dal cielo io vi benedirò”. Essi risposero: “Noi non sappiamo a quale jati appartiene, come faremo a trovarle uno sposo?” Data questa risposta, essi tornarono alle loro case. Allora io abbracciai la nonna e le dissi: “Nonna, non è necessario che io mi sposi, ma quando tu non ci sarai più, con chi starò? Insieme a chi giocherò? Con chi riderò? Insieme a chi sopporterò il peso della vita?” La nonna rispose: “Essi non sanno a quale jati tu appartieni, tesoro, ma io lo so: tu appartieni al jati umano. Se non fosse stato così, l’oceano ti avrebbe risucchiato e tuo padre e tua madre non ti avrebbero salvato la vita. Quando io morrò, tu andrai alla ricerca del jati, a cui appartieni. E adesso, Moni, dammi da bere un sorso d’acqua”. Dopo aver sorseggiato l’acqua, la nonna volse verso di me lo sguardo e sorrise. Poi spirò. Io le chiusi gli occhi e scoppiai a piangere.
Quando le lacrime dei miei occhi si esaurirono, mi alzai. In un angolo della casa era appesa la mia gamcha. Legata alla gamcha la mia palla. Presi la gamcha con la palla, perché anch’io appartengo al jati umano ed un giorno dovrò anch’io salvare mia figlia. Poi uscii di casa per andare alla ricerca del mio jati e mi incamminai sulla spiaggia del mare. Dopo aver camminato a lungo, raggiunsi un villaggio. Al centro del villaggio c’era un mondir (tempio hindu). I fedeli avevano fatto la puja (preghiera rituale) e stavano uscendo. Sul volto di tutti c’era il sorriso. Essi mi piacquero molto e dissi: “Io rimarrò con voi”. Mi chiesero: “Qual è il tuo jati ?” “Il mio è il jati dell’uomo”. “Noi non conosciamo il tuo jati. Cosa vuoi da noi?” “Io resterò con voi”. “Ma il tuo jati è diverso. Vai avanti e cerca nel villaggio qui vicino”.
Ripresi a camminare sulla spiaggia del mare e raggiunsi un altro villaggio. Nel bel mezzo splendeva la cima dorata di un minareto e davanti un’immensa spianata ricolma di gente. Dopo il namaz (preghiera dei musulmani) essi si stavano scambiando l’abbraccio di pace. Mi piacquero molto e dissi: “Io mi fermerò da voi”. “A quale jati appartieni?” “Io sono un essere umano”. “Noi non conosciamo il tuo jati. Vuoi entrare a far parte del nostro jati?” “No, io non farò parte del vostro jati”. “Allora come farai a stare con noi? Vai e cerca più avanti”.
Continuai a camminare lungo la spiaggia del mare. Cammina e cammina, arrivai ad un altro villaggio. I fedeli stavano uscendo di chiesa e sorridendo si scambiavano il saluto fra di loro. Mi piacquero immensamente e dissi: “Io resterò con voi”. “Vuoi tu convertirti?” “No, io non voglio convertirmi, io voglio rimanere quello che sono”. “Allora come farai a rimanere fra di noi? Vai e cerca più avanti”.
Di nuovo proseguii il mio cammino sulla spiaggia del mare. Davanti c’era un altro grosso villaggio: al centro una pagoda. Terminata la preghiera, i fedeli uscirono sulla prospiciente spianata. Qui, sfilando in processione, accesero dei lumini e danzando intonarono dei canti. I loro canti erano molto belli. Dissi: “Io mifermerò qui con voi”. “Qual è il tuo jati?” “Io sono un essere umano”. Una volta in questa nostra contrada c’era un jati di quel genere; tutti i nostri testi sacri ne parlano, ma ora non è più così: quel genere si è dissolto. Tu cosa vuoi da noi?” “Io voglio restare qui con voi”. “Tu non puoi perché il tuo jati è diverso. Vai e cerca più avanti”.
I miei occhi si riempirono di lacrime. Davanti non c’era più nessun villaggio. Tornai verso il mare. Seduta sulla sabbia incominciai a piangere. Mi venne voglia di sprofondare nel mare. Sulla spiaggia del mare ragazzi e ragazze stavano giocando. Essi si accorsero che stavo piangendo. Improvvisamente smisero di giocare. Le loro grida di giubilo cessarono. “Come ti chiami, moni?” “ Lo hai detto tu; il mio nome è Moni” “Perchè piangi?” “Ho fame”. “Su, prendi la mia polpetta dolce”. “Prendi le mie nocelline”. “Prendi il mio muri (riso soffiato abbrustolito”. “Ma gli adulti non mi vogliono”. “E allora? Tu starai con noi”. “A casa di chi mangerò?” “Mangerai nelle nostre case”. “Ma se gli adulti non mi danno da mangiare?” “Noi ruberemo il cibo e te lo daremo. Gli adulti in molte cose sono ignoranti. Bisogna aver pazienza con loro”. “Ma io appartengo ad un jati diverso”. “Perché diverso? Tu piangi come noi, ridi come noi, tu hai fame, ti stanchi… Dunque tu appartieni al nostro jati, tu sei un essere umano”. “E non vorranno sapere niente di più?…” “Assolutamente no! Noi sappiamo tutto: tu sei Moni, tu sai ridere, sai piangere, sai giocare, tu hai fame, tu sei una di noi, tu appartieni al nostro jati”. Ragazzi e ragazze, ai miei due fianchi, mi presero per mano e cominciarono a danzare. Io andai a stare con loro.
di p. Antonio Germano Das, sx. – antoniogermano2@gmail.com